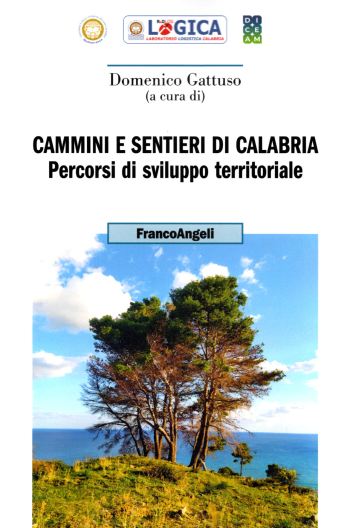Consigli pratici per abbigliamento tecnico e scarpe adatti ad Escursioni, Trekking e per la disciplina sportiva FIE “Marcia Alpina di Regolarità”: Comfort e Sicurezza in Natura
Praticare escursioni, trekking oppure la marcia o camminata di regolarità significa sostanzialmente immergersi nella natura, esplorare sentieri sconosciuti, affrontare sfide fisiche e godere dei paesaggi mozzafiato che solo l’ambiente montano può offrire. Tuttavia, per vivere questa esperienza in totale sicurezza e comfort, è fondamentale scegliere con cura l’abbigliamento tecnico e le scarpe giuste. L’abbigliamento e le calzature non sono solo una questione di stile, ma sono strumenti che permettono di affrontare al meglio le condizioni ambientali e le difficoltà del terreno, migliorando la performance e riducendo il rischio di infortuni. In questo contributo, esploreremo le caratteristiche principali dell’abbigliamento e delle scarpe ideali per praticare l’Escursionismo in tutte le sue declinazioni.
1. L’ Abbigliamento Tecnico: cosa indossare per stare bene e sempre in comfort?
a. Giacche e giubbotti impermeabili e traspiranti
Le condizioni atmosferiche in montagna possono variare drasticamente nel corso della giornata, con piogge improvvise, vento forte e temperature che oscillano. È quindi essenziale indossare un buon giubbotto o una giacca impermeabile e traspirante. I materiali più adatti per queste giacche sono il Gore-Tex, il Paclite o il Dermizax, perchè offrono una protezione efficace contro l’acqua mantenendo una buona traspirabilità, permettendo così al sudore di evaporare. Inoltre, un buon capospalla per questo genere di attività all’aria aperta deve essere leggero, ma allo stesso tempo resistente a intemperie come la neve o la pioggia. Questi suggerimenti naturalmente valgono anche nel praticare la marcia di regolarità durante la stagione autunnale/invernale (durante le ultime prove del tradizionale campionato) oppure a inizio stagione agonistica, specie quando il tempo in questi periodi è incerto e può capitare che si disputino le prove sotto la pioggia o al freddo.
b. Strati per la termoregolazione
Una delle regole fondamentali per un’escursione o lo sport praticato in montagna è quella dei “3 strati”. Questo sistema consente di adattarsi alle variazioni di temperatura e di attività durante la camminata. Il primo strato, chiamato “strato di base“, è a contatto diretto con la pelle e deve essere in materiali sintetici (come il poliestere) o in lana merino, che garantiscono un’ottima gestione dell’umidità. Il secondo strato, lo “strato medio“, serve per trattenere il calore ed è spesso costituito da pile o materiali sintetici come il Primaloft. Infine, il terzo strato è lo “shell“, ovvero una giacca impermeabile e antivento.
c. Pantaloni
I pantaloni devono essere resistenti, traspiranti e capaci di adattarsi ai cambiamenti climatici. I modelli più adatti sono quelli con tessuti resistenti agli strappi, come il nylon o il poliestere, ma allo stesso tempo leggeri e comodi per consentire libertà di movimento. I pantaloni con cerniere sui fianchi, che consentono di trasformarsi in pantaloncini, sono molto utili per adattarsi alle temperature più calde. In caso di escursioni in ambienti freddi o montani, i pantaloni imbottiti o con una leggera fodera in pile possono essere una scelta efficace. Per quanto riguarda la marcia o camminata di regolarità, durante la stagione primaverile ed estiva si possono utilizzare i tipici pantaloni da Trail running, come ad esempio i pantaloni a 3 quarti oppure pantaloni corti anche a mezza coscia, sempre in tessuto traspirante, ma comodi per permettere di camminare senza intralci.
d. Calze tecniche
Le calze da indossare sono un altro aspetto fondamentale da considerare. Devono essere realizzate in materiali sintetici o in lana merino, che aiutano a mantenere i piedi asciutti e caldi. Le calze tecniche offrono anche un buon supporto al piede, riducendo il rischio di vesciche e migliorando il comfort durante le lunghe camminate. È importante scegliere calze senza cuciture e con una buona protezione nelle zone più sensibili come il tallone e la pianta del piede.
e. Cappelli, guanti e occhiali da sole
Un altro dettaglio importante riguarda gli accessori: il cappello deve proteggere dal sole e, se necessario, dalle intemperie. Durante la stagione autunnale e invernale i guanti, leggeri e traspiranti, sono sempre utili in caso di escursioni in montagna in ambienti freddi, mentre gli occhiali da sole con protezione UV sono essenziali per proteggere gli occhi da raggi solari riflessi sulle superfici neve o rocciose.
2. Quali scarpe per l’Escursionismo?
Le scarpe sono uno degli equipaggiamenti più importanti per qualsiasi attività all’aria aperta, e la scelta delle scarpe giuste è fondamentale per affrontare in sicurezza sentieri impervi e terreni difficili o percorsi tecnici.
Una buona scarpa da trekking deve garantire stabilità, protezione, resistenza e comfort durante tutta l’escursione.
a. Tipologia di scarpe per l’Escursionismo
Sia che venga praticato l’Escursionismo nelle sue varie forme che la marcia o camminata di regolarità, un’attenzione particolare va’ sempre riservata alla scelta delle scarpe da indossare, a seconda del tipo di terreno e dell’intensità dell’attività.
In generale è sempre meglio orientarsi per un modello che possa offrire supporto alla caviglia, proteggendo il piede dagli urti e dai detriti.
In caso di avventura in alta montagna o nel caso di competizioni di marcia di regolarità particolarmente lunghe e impegnative (i campionati per pattuglie, ad esempio), è suggeribile orientarsi su scarponi da trekking, perché consentono di affrontare terreni accidentati, trekking con zaini pesanti, eventuale attraversamento di superfici fangose o bagnate.
b. Caratteristiche delle scarpe
Le scarpe da trekking devono possedere alcune caratteristiche fondamentali per garantire un’ottima performance.
La suola deve essere rigida, ma flessibile nella parte anteriore, per adattarsi ai movimenti del piede. Inoltre, la gomma con un buon grip (come la Vibram) aiuta a garantire aderenza su terreni bagnati e scivolosi. L’imbottitura interna è fondamentale per migliorare il comfort, evitando la formazione di vesciche. La presenza di una membrana impermeabile, come il Gore-Tex, è fondamentale per mantenere il piede asciutto in caso di pioggia o attraversamenti di torrenti. Infine la ventilazione, consentita dal mesh traspirante, nonostante l’impermeabilità, serve a evitare che il piede sudi eccessivamente.
Conclusioni
Sia che si tratti di un’escursione di un giorno, di un trekking più impegnativo o della marcia o camminata di regolarità, la scelta dell’abbigliamento tecnico e delle scarpe giuste è cruciale per vivere l’esperienza in montagna in totale sicurezza e comfort. Investire in capi e scarpe di qualità non solo migliora la performance, ma riduce anche il rischio di infortuni e aumenta il piacere di esplorare la natura. Con l’attrezzatura adatta, ogni camminata diventa un’avventura entusiasmante e sicura!
L’articolo Abbigliamento escursionismo e marcia o camminata di regolarità proviene da FIE Italia – Federazione Italiana Escursionismo.