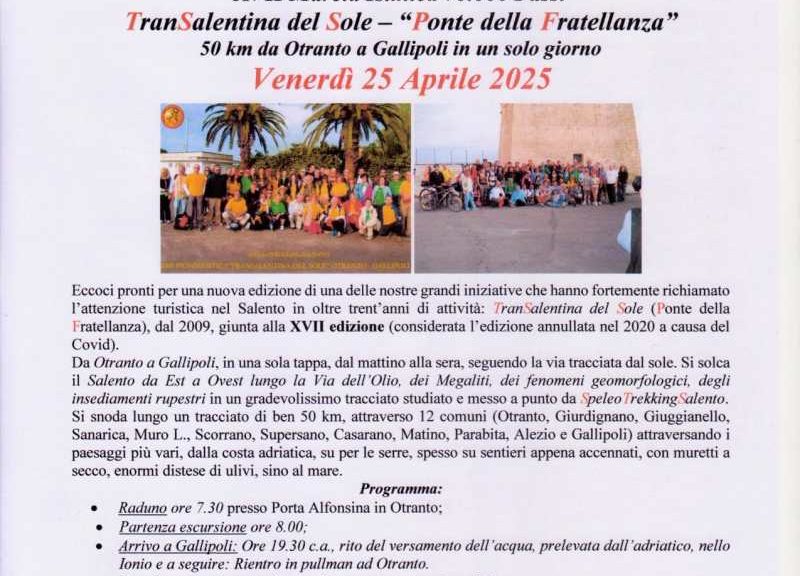Evitare le dolorose vesciche durante un’escursione in montagna non è solo questione di fortuna, ma di scelta oculata dell’equipaggiamento e di piccoli accorgimenti quotidiani che fanno la differenza tra una camminata piacevole e una sofferenza evitabile. Iniziare dalla qualità delle calze è fondamentale: i modelli tecnici, realizzati con fibre sintetiche ad alte prestazioni o con lana merino, garantiscono una gestione ottimale dell’umidità e un’efficace termoregolazione. La superficie interna deve essere morbida e uniforme, priva di cuciture sporgenti, mentre quella esterna resistere all’usura e favorire lo scorrimento della calzatura. Scegliere calze anatomiche, con rinforzi mirati su tallone e punta, riduce l’attrito nei punti più sollecitati dal movimento e protegge la pelle dall’insorgenza di punti caldi, responsabili delle famigerate vesciche.
Il materiale è il primo elemento da tenere in considerazione: le calze in lana merino offrono un’eccezionale capacità di regolare la temperatura, mantenendo i piedi caldi anche a basse temperature e asciutti grazie alle naturali proprietà antibatteriche della fibra. Le alternative sintetiche, invece, come poliammide e polipropilene, vantano un’elevata resistenza all’abrasione, un’asciugatura rapidissima e un’elasticità che segue i movimenti del piede senza costrizioni. Molti marchi specializzati propongono calze “ibride”, che combinano lana merino nella parte interna a componenti sintetici sugli strati esterni, assicurando il miglior compromesso tra comfort, durata e gestione dell’umidità. In ogni caso, è essenziale evitare il cotone tradizionale: assorbe l’umidità e resta a contatto con la pelle, creando un ambiente ideale per la formazione di vesciche.
Un aspetto spesso trascurato dai principianti è la scelta tra calze a strato singolo e sistemi a doppio strato. Le calze a doppio strato, costituite da un guscio interno aderente e uno esterno leggermente più largo, sfruttano il principio dello scorrimento tra i due tessuti: mentre il piede si muove con la calza interna, lo strato esterno segue il movimento della scarpa, riducendo drasticamente l’attrito diretto sulla pelle. Questa soluzione, nata per il trekking di lunga durata e per le competizioni di trail running, ha dimostrato di limitare quasi completamente la comparsa di bolle, purché entrambe le calze vestano correttamente e non si stacchino o si raggrinziscano all’interno dello scarpone.
La misura e l’aderenza della calza sono determinanti: un’eccessiva compressione provoca costrizioni e irritazioni, mentre una taglia abbondante crea pieghe che strofinano il piede. Prima di ogni uscita, è consigliabile indossare le calze nuove in casa, verificando che non si formino grinze quando si piega il piede o si cammina per qualche decina di passi. Le calze tecniche devono avvolgere l’arco plantare con elasticità, senza lasciare spazi vuoti tra polpaccio, caviglia e piede. Per chi ha differenti misure tra piede destro e sinistro, è opportuno acquistare calze per ogni piede: molti produttori indicano la taglia per ciascun piede e offrono confezioni miste.
La calza perfetta, però, opera in sinergia con la calzatura: inserire plantari personalizzati o solette tecniche può correggere automaticamente la postura del piede, distribuire meglio il peso e ridurre i punti di pressione. Indossare le calze insieme alle scarpe in negozio o a casa, con le solette già inserite, consente di valutare l’abbinamento migliore. Una lacciatura ben eseguita – con nodi intermedi che blocchino il tallone senza comprimerlo – aiuta a mantenere fermo il piede, prevenendo micro-movimenti e conseguenti sfregamenti. In situazioni di salita ripida o discesa tecnica, una seconda asola di blocco sulla caviglia stabilizza ulteriormente la calzatura, aumentando precisione e comfort.
Non meno importante è la cura della pelle e delle unghie: un taglio regolare, dritto e poco profondo, previene l’insorgere di unghie incarnite e riduce il rischio di distaccamenti sottocutanei. Applicare quotidianamente una crema idratante specifica – con ingredienti quali urea e pantenolo – rinforza la barriera cutanea, rendendo la pelle più elastica e meno propensa a lesioni. Nei punti considerati “a rischio” (mignolo, tallone, metatarso), si possono applicare cerotti protettivi o utilizzare nastri in tessuto “abrasivo” che spostano l’attrito dalla pelle al nastro stesso. Per escursioni molto lunghe, portare con sé dei piccoli ritagli di cerotti idrocolloidali permette di intervenire sul primo segno di irritazione, evitando l’evoluzione in vesciche piene di liquido.
Durante la camminata, mantenere il piede asciutto è indispensabile. In giornate calde o in percorsi fangosi, il cambio delle calze a metà giornata costituisce un’abitudine vincente: lasciare che i piedi si aerino qualche minuto al sole o all’aria aperta riduce rapidamente l’umidità. Utilizzare bustine sigillate per le calze di ricambio e inserire all’interno del mezzocalzino un piccolo sacchetto di gel di silice (quello che si trova nelle confezioni di elettronica) aiuta a mantenere l’essiccazione. Se l’acqua penetra nella scarpa o nello scarpone, estrarre la soletta interna e scuotere l’eccesso d’acqua prima di riporre di nuovo la scarpa nello zaino è un gesto semplice che ripaga con una sensazione di freschezza immediata.
Alla fine della giornata, la manutenzione delle calze tecniche è un passaggio fondamentale per garantirne durata e performance future. Lavare sempre in acqua fredda o tiepida, evitando temperature elevate che rovinano le fibre elastiche, e usare detersivi delicati privi di ammorbidenti: questi ultimi tendono a depositarsi sulle fibre, riducendo la capacità di traspirazione. Non centrifugare a velocità eccessive e stendere all’ombra, lontano da fonti di calore diretto e raggi solari intensi. Conservare le calze in un luogo asciutto e ventilato, lontano da cassetti umidi o aree soggette a sbalzi termici, per evitare la formazione di muffe o odori sgradevoli.
Integrare questi piccoli ma preziosi accorgimenti nella routine dell’escursionista significa trasformare un’esperienza potenzialmente dolorosa in una passeggiata rigenerante. Le vesciche non sono un destino ineluttabile: con la giusta conoscenza dei materiali, l’attenzione al fitting e una corretta cura della pelle, è possibile dedicarsi al piacere del cammino senza fastidi. Ogni escursione diventa così un’opportunità per apprezzare i panorami, concentrarsi sul respiro e ottenere il massimo benessere fisico e mentale che solo la montagna sa donare.
L’articolo Come evitare vesciche: calze tecniche e piccoli accorgimenti vincenti proviene da FIE Italia – Federazione Italiana Escursionismo.